Storia e Parco
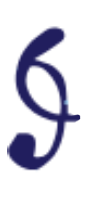
Nascita del complesso
La storia ultrasecolare di un complesso che da sempre ha affascinato ed incuriosito per bellezza e particolarità
I terreni su cui sorge la dimora, con le sue dipendenze, vennero in possesso del negoziante Pietro Caramora (nativo di Vigevano, ma residente a Torino) per acquisto da Andrea Cardonat nel 1878; ulteriori ampliamenti della proprietà sono attestati nel 1885 e nel 1895, questi ultimi coincidenti con i nuovi acquisti di Carlo Caramora, figlio di Pietro che in quegli anni fece realizzare il complesso immobiliare.
Scopri di più...
Come riportato su “La Stampa” del 17 Gennaio 1896 Carlo Caramora, invitando oltre cento amici dal pinerolese e da Torino, tra cui il famoso sensitivo Gustavo Rol, organizzò il Pranzo della neve, un evento conviviale informale, a garanzia della cui informalità fece affiggere nella sala da pranzo un grosso cartello con la scritta:
”Vietati i discorsi”.
In seguito alla morte di Carlo Caramora, definito dai suoi contemporanei filantropo e benefattore, nel 1905 la proprietà passò agli eredi e venne poi ceduta nel 1929 all’industriale Vincenzo Priotti, originario del pinerolese, ma residente a Parigi, per una cifra di 400.000 lire dell’epoca. L’atto pubblico di vendita descrive a quel tempo la casa di villeggiatura su tre piani, di diciannove vani, con giardino, scuderia, rimessa e serra per fiori, unitamente ai fabbricati di servizio.
Dalla relazione di perizia dell’ing. Carlo Jorio:
“Il suo prospetto è a finto legno, il che dà alla costruzione – anche per la forma del tetto – l’aspetto di uno chalet. Al di sopra dell’entrata principale vi è una grande pensilina a vetri a ventaglio”; dieci degli ambienti risultano essere “convenientemente decorati”.


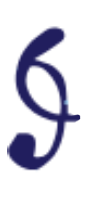
Dettagli ornamentali
La ricchezza decorativa di interni ed estreni
Pur mancanza di una fonte specifica che ne definisca lo stile, possiamo suggerire che la Villa la Sorridente sia verosimilmente realizzata in uno stile eclettico ottocentesco, in linea con l’ornato e l’estetica dell’epoca. Secondo archivi del Politecnico di Torino lo stile della residenza appartiene al filone ottocentesco dello “chalet” (stile svizzero) – tetto a capanna, sporti marcati, balconate e modanature lignee, tipico dell’eclettismo del tempo.
Scopri di più...
Nel complesso ricorrono le “righe sabaude” (fasce ocra/marrone) che sono più una cifra identitaria dell’insieme che un vero “stile” a sé, ma piuttosto frequenti in un contesto stilistico tipico del Piemonte dell’ottocento. Villa la Sorridente è dunque un esempio di chalet romantico ottocentesco, con un linguaggio architettonico che richiama la montagna, il legno e le decorazioni funzionali, arricchita da elementi in stile Liberty, con decori floreali, linee sinuose e un gusto sofisticato, come ad esempio la pensilina in ferro, una sottile struttura aggettante posta sopra l’ingresso principale, caratterizzata da linee sobrie e decoro discreto che si integra elegantemente nella facciata, fungendo da protezione funzionale e da raffinato elemento ornamentale, rappresentativo dell’estetica Liberty piemontese di fine Ottocento.
Un altro elemento di particolare interesse è un orologio a pendolo “Morbier”, un modello nato nel Jura francese a partire dal XVII secolo e diffusissimo nelle case e nelle ville tra Settecento e Ottocento. Quello di Villa La Sorridente è un caso particolare e suggestivo per la sua collocazione esterna: il quadrante è incassato nella muratura, diventando una sorta di “orologio pubblico” visibile a chi arrivava alla villa, così da servire non solo agli abitanti, ma anche a chi lavorava o frequentava la villa (domestici, ospiti, giardinieri), scandendo la giornata senza bisogno di portare orologi personali.
Esibire un Morbier in facciata era anche segno di prestigio e modernità; incassare un orologio pensato per interni in una facciata è un gesto singolare, che trasforma l’oggetto in parte integrante della composizione Liberty della villa.
Traendo ulteriormente spunto dalla preziosa analisi storiografica ed artistica offerta dai dottori Sonia Damiano e Marco Fratini nel testo di recente pubblicazione “San Secondo di Pinerolo – Immagini e Storie di un paese del Piemonte”, dalla descrizione dei mobili predomina la presenza, all’esterno, di elementi decorativi in terracotta, materiale forse prodotto nelle locali fabbriche di laterizi, e di cui ancora si compone la balaustrata di due terrazzi ben visibili dalla strada, di gusto che potrebbe definirsi eclettico, con mascheroni leonini sulle lesene dei pilastrini, ulteriormente decorata da trofei a forma di vaso con frutti, già attestata in una fotografia di Carlo Chiampino del 1929. Parte degli interni, infernotto della cantina incluso, presentano una decorazione di gusto liberty, forse stesa in più campagne decorative, a motivi in prevalenza floreali a intreccio, di più o meno accentuata stilizzazione, quando non a figure femminili e putti alati. Splendida e rara, infine, la boiserie a tutta volta dello studiolo al pian terreno.
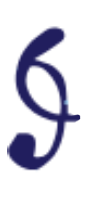
Giardino ed edifici
L’assetto organizzativo del giardino e gli edifici minori
Le informazioni riguardanti l’assetto del giardino nel primo Novecento sono state desunte dalla descrizione che Clelia, moglie di Vincenzo Priotti, ne faceva ai suoi amici. È presumibile che il giardino si caratterizzasse per una struttura molto simile all’attuale già all’arrivo dei Priotti, nel senso che sia i vialetti interni, sia la distribuzione delle macchie boscate e delle aiuole erano consolidati già da tempo. Semmai, con gli anni, vi fu la volontà di andare ad infittire ed arricchire con nuovi esemplari alcune zone.
Scopri di più...
Anche la vasca antistante la villa a mezzogiorno, poi scomparsa con la recente ristrutturazione, era già presente nel ’29. Per quanto riguarda invece i numerosissimi esemplari di palme (Trachicarpus fortunei) che caratterizzavano e sottolineavano in maniera forse eccessivamente insistente la viabilità interna fino alla fine degli anni ’90 del Novecento, va rimarcato come essi fossero il risultato di un’incessante opera di messa a dimora da parte della proprietà anche lungo tutta la seconda metà del Novecento.
Nei pressi della suddetta vasca si trovava una voliera a pianta esagonale, ad ospitare varie specie di volatili, ed il parco era abitato di giorno anche da splendidi pavoni, la cui voliera, di dimensioni maggiori, era dislocata a mezzogiorno della serra, verso la scuderia.
Oltre all’edificio principale, nel parco trovano ancora oggi posto altri edifici secondari, fra cui a nord la casa del custode, le rimesse e il “solitaire”, la palazzina dalle linee neogotiche per gli ospiti; a sud la legnaia; a sud-ovest la scuderia, con annesso granaio-fienile e terrazzo ad uso essiccatoio per i cereali, la casa del giardiniere, ed ancora la serra, munita di stufe per il riscaldamento ad aria, fornita anche di bancali con tubi per il riscaldamento dal basso dei semenzai e pianali a gradinata per la protezione invernale dei gerani e dei limoni. Appena al di fuori della serra i semenzai esterni, con i vetri basculanti. Un altro elemento di notevole interesse è rappresentato da un finto pozzo realizzato utilizzando lastre di marmo di epoca rinascimentale.
La vasca a cui si è accennato prima veniva alimentata a mezzo di acqua proveniente da una sorgente di collina, con adduzione da tubi sotterranei. L’acqua in surplus finiva in un’ulteriore coppia di vasche sotterranee di raccolta, poste sotto il viale, davanti al solitaire, nelle quali si convogliavano anche le acque di gronda degli edifici. Una pompa captava l’acqua da queste vasche e alimentava quindi l’impianto di irrigazione. Un giardiniere, impiegato a tempo pieno, si occupava della gestione dell’intero complesso.


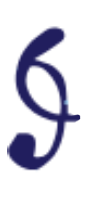
Vegetazione suggestiva
La ricchezza botanica e la notevole suggestione paesaggistica nel parco
Gli esemplari arborei ed arbustivi nel parco, pur gravemente danneggiato da un tornado nel novembre 1980, ricalcano ancor oggi la disposizione a macchie, con il ritmo compositivo dato dall’intersecarsi di tortuosi percorsi inghiaiati, fino a terminare, a nord, in un’area più naturaliforme, sulla scarpata di un piccolo rio.
Scopri di più...
Tralasciando per brevità la componente arbustiva ed erbacea, molte sono le specie arboree individuabili, con una netta predominanza dei sempreverdi. Fra questi ultimi citiamo i cedri del Libano e dell’Himalaya (Cedrus libani e C. deodara), la camelia (Camelia japonica), i cipressi di Lawson, del Giappone, nostrano e rosso occidentale (Chamaecyparis lawsoniana, Cryptomeria japonica, Cupressus sempervirens e Thuja plicata), la palma (Trachicarpus fortunei), l’abete dalla Cina (Cunninghamia lanceolata), l’agrifoglio (Ilex aquifolium), la magnolia bianca (Magnolia grandiflora), l’abete di Koster (Picea pungens), la wellingtonia (Sequoiadendron giganteum), presente con due immensi esemplari, purtroppo alla fine del loro ciclo vitale, la stranvesia (Stranvaesia davidiana), il tasso (Taxus baccata).
Fra le caducifoglie gli aceri giapponese, riccio e americano (Acer palmatum, A. platanoides e A. negundo), il castagno europeo (Castanea sativa), il faggio (Fagus sylvatica), il frassino maggiore (Fraxinus excelsior), il mirabolano (Prunus cerasifera), la farnia e la quercia americana (Quercus robur e Q. rubra), il tiglio americano (Tilia americana).
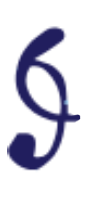
Rilancio del complesso
Le ultime trasformazioni e la destinazione attuale
Grazie all’ultimo e recente passaggio di proprietà, Villa La Sorridente è oggi un esempio di come creare sviluppo abbinando la valorizzazione del patrimonio e delle risorse locali alle opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione e comunicazione. In quest’ottica, il complesso immobiliare, con le sue pertinenze verdi, è stato trasformato in una location per ospitare eventi aziendali, corsi di formazione e attività di team building.


